Gli strumenti per la misura del tempo sul Torrazzo di Cremona
La comprensione del tempo e la sua misura sono stati certamente uno dei più importanti problemi affrontati dall’uomo nel corso dei secoli; un grande orologio o una funzionale meridiana erano simbolo di prestigio, strumenti scientifici, norme di vita.
La volta celeste che ci sovrasta e ammiriamo in una notte serena è una parte dell’Universo, in cui bruciano grandissimi globi di fuoco e si muovono astri che fin dall’antichità hanno affascinato gli uomini e destato il loro interesse.
L’orologio astronomico è una rappresentazione del cielo, ove le costellazioni dello zodiaco sono ciclicamente attraversate, nel loro perenne moto apparente, dal Sole e dalla Luna: gli astri che da millenni hanno segnato il tempo dell’uomo.
La grande dimensione della torre del Duomo di Cremona ben si prestava a realizzare un quadrante eccezionalmente ampio, la cui superficie super abbondantemente i 50 m
2, forse il più grande al mondo. Il quadrante originale rappresentava tutto il sapere astrologico-astronomico dell’epoca, una mirabile sintesi della cultura antica, medioevale e rinascimentale.
L’orologio astronomico e i suoi meccanismi
Un peso (o grave) è legato ad una fune e questa avvolta su un tamburo, secondo l’antico sistema dei verricelli utilizzati per sollevare l’acqua dai pozzi. È questa la fonte di energia per l’orologio.
Mediante un sistema di ruote dentate (traino o treno del tempo), il movimento del tamburo è ampliato fino ad una ruota, detta coronata per dei particolari pioli entro i quali agisce il sistema di “scappamento”. Questo, tramite un pendolo che fornisce un periodo regolare, lascia “scappare” la ruota coronata, trasmettendo così la misura del tempo all’intero meccanismo.
Un altro grave fornisce l’energia per il suono delle ore. Attraverso il consenso fornito da una camma del treno del tempo, il meccanismo mette in movimento una speciale ruota chiamata partiora, che ruota in modo rigorosamente uniforme; questa reca al suo interno tanti incavi di lunghezza crescente, ogni incavo della partiora determina il preciso numero di rintocchi della campana.
Anche il gruppo di ingranaggi che servono al moto planetario, o macchina astronomica, prende energia di moto da un proprio grave che fornisce la potenza, mentre il comando all’azione arriva sempre dal treno del tempo; ciò perché lo sforzo necessario ai movimenti della macchina astronomica non infici il buon andamento o costanza della macchina del tempo. Intelligente sistema applicato per la prima volta.
Sono tre macchine interagenti costituenti un complesso meccanismo, veramente straordinario per la tecnologia del tempo, che oggi troviamo sostanzialmente integro, tranne l’applicazione del pendolo che ne ha assicurato una maggior precisione.
Per quanto riguarda la mostra, o quadrante esterno, i continui rifacimenti necessari a fronte dell’ingiuria del tempo lo hanno impoverito delle parti astrologiche ritenute obsolete, ma che lo rendevano eccezionale, bello e unico nel suo genere.

La meridiana esterna e quella della sala del meccanismo
Anche le meridiane rivestono un ruolo molto importante nell’evoluzione della misura del tempo, infatti hanno “accompagnato” per molti secoli l’evoluzione dell’orologeria meccanica fungendo da preciso riferimento per la taratura; l’istante utilizzato per la regolazione era costituito dall’immagine del Sole, nel momento del transito in meridiano, o mezzogiorno locale.
La meridiana esterna, che porta l’equazione del tempo medio, quello degli orologi pubblici, fu realizzata dal generale Pistoia nel 1910 su una precedente che è andata irrimediabilmente perduta. Quella interna, nella sala del meccanismo, presenta una tribolata realizzazione e ricerca di perfezione. Il tracciato originario potrebbe risalire a quel primo orologio della torre di cui si hanno incerte notizie.
Al di là della loro applicazione pratica e del valore artistico che portano, questi antichi strumenti forniscono ancora importanti indicazioni.
Sono figli delle abilità degli artisti che li hanno saputi realizzare e costituiscono un prezioso patrimonio per la nostra cultura scientifica, storica e religiosa; il loro valore giustifica il desiderio di conservazione.
Osservare la meridiana che interagisce con la luce o ascoltare il battito preciso e possente dello scappamento del grande orologio, che imperterrito funziona da mezzo millennio, genera sempre in noi una grande ammirazione e soddisfazione.

Il quadrante originale
La magnificenza di quest’opera, notevole per la quantità di responsi che elargiva, realizzata sulla maggior torre campanaria italiana, è conseguenza del clima di cultura e prosperità che la città di cremona ereditava dall’età comunale e conservava all’epoca delle signorie.
Dalle fonti storiche disponibili sembrerebbe che il primo quadrante apparso sulla gran torre avesse un diametro di circa 4 metri, come risulta da un documento dei Prefetti della Fabbriceria datato 1471, da un dipinto del Campi e da una bella tarsia che lo rappresenta nel IX stallo di sinistra del coro della Cattedrale.
Il successivo orologio dei Divizioli (padre e figlio), era decisamente più ambizioso, il quadrante misurava oltre 8 metri di diametro e fu dipinto sulla torre da Giova Battista Dordoni e Martino Pesenti su indicazioni dei Divizioli stessi.
Nel centro del quadrante si trovava il disco rappresentante la Terra, da questo si dipartiva l’indice per il computo dell’ora, letta sulla corona più esterna, divisa in 24 spazi uguali segnati da numerazione romana.
La posizione della prima ora era posta appena sotto una immaginaria linea orizzontale che attraversava al centro il quadrante, richiamando l’orizzonte. All’epoca, infatti, il giorno iniziava appena dopo il tramonto del Sole: al di sotto di questo immaginario orizzonte abbiamo le ore della notte, al di sopra quelle del giorno.

Intorno al disco della Terra si trovava quello della Luna con l’indice lunare. Sopra questo disco, tre figure geocentriche (un triangolo, un quadrato ed
un esagono) rappresentano un terzo, un quarto ed un sesto della volta celeste, e sono chiamati anche trigono, quadratura e sestile.
Queste figure, con un vertice comune “nell’occhio” della Luna, avevano, oltre ad un significato astronomico di congiunzione, opposizione, quadratura o frazione di cielo, anche dei significati astrologici.
La Luna era tenuta in grandissima considerazione per gli effetti e le influenze che poteva esercitare sulla natura e sulle persone; questi effetti erano spiegati considerando la sua fase, mostrata nel foro del disco stesso e le configurazioni celesti. L’indice della luna ruotava in senso antiorario, compiva un giro in un mese indicando attraverso le “case planetarie”, tra quali stelle l’astro si trovasse.
“Sul quadrante ci sono cinque indici che muovono con artifizio mirabile guidati dalla ruota dell’Orologio.
L’indice primo denota le ore del giorno,
il secondo è del Sole che dimostra il giorno del mese, in qual grado, e segno dello zodiaco si trova il Sole, e con quale Stella cammini,
l’indice terzo è della lunazione, che dimostra il giorno della Luna ed il qual grado e segno dello zodiaco.
Due altri indici che sono il capo e la coda del Dragone che dimostrano l’eclissi.”
Francesco Divizioni e il suo quadrante cinquecentesco

Il lato retto dell’indice del supporto della Luna permetteva di conoscere il giorno di lunazione attraverso una numerazione che arrivava fino a 29½ (mese sinodico o intervallo di tempo tra due ritorni dell’astro alla stessa fase). Interessante la credenza secondo la quale fase lunare e combinazioni planetarie potessero determinare periodi di piogge, questi erano indicati sulla prima corona non mobile del quadrante, sopra lo spazio riservato al moto dell’astro diurno e notturno.
Intorno al disco della Luna si trovava il disco del Sole. Anch’esso ruotava in senso antiorario, l’asta con questo solidale compiva un giro in un anno e mostrava quali stelle accompagnavano il cammino dell’astro, la casa zodiacale in cui si trovava, il mese e il giorno.
Ruotava invece in senso orario un doppio indice recante la testa e la coda di un drago, mitologico animale responsabile delle eclissi. Questo indice riusciva a predire il fenomeno, in quanto gli ingranaggi che lo muovevano riproducevano il “ciclo di Saros”, individuato per la prima volta dai Caldei, antico popolo della Mesopotamia. Le aste del drago compivano un giro completo del quadrante in 18 anni e 214 giorni. Scientificamente il fenomeno si spiega perché i piani orbitali della Terra e della Luna sono reciprocamente inclinati di 5 gradi. I punti di intersezione dei due piani sono detti “nodi”. Questi, in cielo, si spostano con la stessa velocità delle aste del drago e sono complanari al Sole; infatti, perché vi sia un’eclissi, i tre corpi celesti: Sole, Terra e Luna (eclissi di Luna), o Sole, Luna e Terra (eclissi di Sole), devono essere perfettamente allineati. Grande meraviglia desta il fatto che l’orologio sia in grado di segnalare un’eclissi che può avvenire in qualsiasi parte della Terra.

Sulle corone più esterne erano indicate le “case planetarie” con la classica simbologia astrologica che specifica se si tratta di segni fissi, mobili o comuni (FIX, MO, CO), o di segni mascolini o femminei (M o F). Erano pure indicate le caratteristiche del segno in relazione alla teoria aristotelica dei quattro elementi (terra, aria, acqua, fuoco).
Purtroppo l’ingiuria del tempo ben presto scolorì sulla torre il dipinto. Già nel 1623, anno della morte di Francesco Divizioli, si eseguì un primo restauro conservativo, altri ne seguirono.
Un radicale sconvolgimento del quadrante avvenne nel “secolo dei lumi”. L’occasione per il rifacimento generale del quadrante fu offerta ad Amicino Ravizza (1757-1815), insegnante del ginnasio cittadino, costruttore di strumenti scientifici e sopraintendente all’orologio. Convinto assertore del rinnovamento, il Ravizza colse l’ordine dell’Imperial Regio Governo Austriaco che voleva una numerazione per gli orologi pubblici in doppia scala da I a XII, con mezzogiorno e mezzanotte sulla verticale, secondo l’uso d’oltralpe.
In quel rifacimento soppresse gran parte delle indicazioni di carattere astrologico, riducendo così la bellezza, la ricchezza e l’eccezionalità di un quadrante che voleva rendere pubbliche cose che appartenevano soltanto agli uomini dotti. Il moto degli indici è sempre rimasto lo stesso.
PDF nelle versioni stampabili:
 Schede_salaquadrante
Schede_salaquadrante

 Dominano i tipici colori della campagna che circonda la città, i quali variano al variare delle stagioni offrendo un panorama in continuo cambiamento.
L’occhio del visitatore rimane rapito dallo scenario che può ammirare da un punto di osservazione così privilegiato, che svetta alto sopra tutto e sopra tutti, avvicinandoci al cielo e a Dio.
Dominano i tipici colori della campagna che circonda la città, i quali variano al variare delle stagioni offrendo un panorama in continuo cambiamento.
L’occhio del visitatore rimane rapito dallo scenario che può ammirare da un punto di osservazione così privilegiato, che svetta alto sopra tutto e sopra tutti, avvicinandoci al cielo e a Dio.


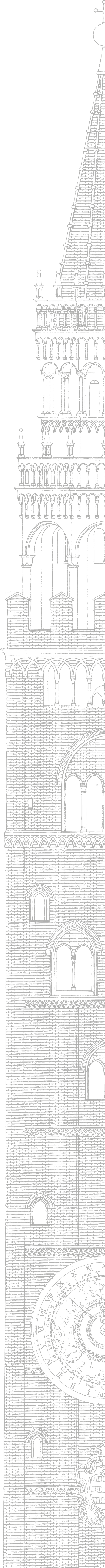























 Nella sala è presente una riproduzione del famoso Artificio di Toledo, opera di Janello Torriani. L'illustre cremonese compare nei documenti come curatore dell'orologio astronomico del Torrazzo.
L'Artificio era la più grande macchina del tempo, veramente ciclopica. Utilizzava la sola energia prodotta dalla corrente del fiume Tago per portare in continuazione l'acqua del fiume alla fortezza dell'Alcàzar, sopra uno sperone di roccia ad un'altezza di circa 100 metri. L'opera idraulica utilizzava concetti di orologeria.
PDF nelle versioni stampabili:
Nella sala è presente una riproduzione del famoso Artificio di Toledo, opera di Janello Torriani. L'illustre cremonese compare nei documenti come curatore dell'orologio astronomico del Torrazzo.
L'Artificio era la più grande macchina del tempo, veramente ciclopica. Utilizzava la sola energia prodotta dalla corrente del fiume Tago per portare in continuazione l'acqua del fiume alla fortezza dell'Alcàzar, sopra uno sperone di roccia ad un'altezza di circa 100 metri. L'opera idraulica utilizzava concetti di orologeria.
PDF nelle versioni stampabili:




 Intorno al disco della Terra si trovava quello della Luna con l’indice lunare. Sopra questo disco, tre figure geocentriche (un triangolo, un quadrato ed
un esagono) rappresentano un terzo, un quarto ed un sesto della volta celeste, e sono chiamati anche trigono, quadratura e sestile.
Queste figure, con un vertice comune “nell’occhio” della Luna, avevano, oltre ad un significato astronomico di congiunzione, opposizione, quadratura o frazione di cielo, anche dei significati astrologici.
La Luna era tenuta in grandissima considerazione per gli effetti e le influenze che poteva esercitare sulla natura e sulle persone; questi effetti erano spiegati considerando la sua fase, mostrata nel foro del disco stesso e le configurazioni celesti. L’indice della luna ruotava in senso antiorario, compiva un giro in un mese indicando attraverso le “case planetarie”, tra quali stelle l’astro si trovasse.
“Sul quadrante ci sono cinque indici che muovono con artifizio mirabile guidati dalla ruota dell’Orologio.
L’indice primo denota le ore del giorno,
il secondo è del Sole che dimostra il giorno del mese, in qual grado, e segno dello zodiaco si trova il Sole, e con quale Stella cammini,
l’indice terzo è della lunazione, che dimostra il giorno della Luna ed il qual grado e segno dello zodiaco.
Due altri indici che sono il capo e la coda del Dragone che dimostrano l’eclissi.”
Francesco Divizioni e il suo quadrante cinquecentesco
Intorno al disco della Terra si trovava quello della Luna con l’indice lunare. Sopra questo disco, tre figure geocentriche (un triangolo, un quadrato ed
un esagono) rappresentano un terzo, un quarto ed un sesto della volta celeste, e sono chiamati anche trigono, quadratura e sestile.
Queste figure, con un vertice comune “nell’occhio” della Luna, avevano, oltre ad un significato astronomico di congiunzione, opposizione, quadratura o frazione di cielo, anche dei significati astrologici.
La Luna era tenuta in grandissima considerazione per gli effetti e le influenze che poteva esercitare sulla natura e sulle persone; questi effetti erano spiegati considerando la sua fase, mostrata nel foro del disco stesso e le configurazioni celesti. L’indice della luna ruotava in senso antiorario, compiva un giro in un mese indicando attraverso le “case planetarie”, tra quali stelle l’astro si trovasse.
“Sul quadrante ci sono cinque indici che muovono con artifizio mirabile guidati dalla ruota dell’Orologio.
L’indice primo denota le ore del giorno,
il secondo è del Sole che dimostra il giorno del mese, in qual grado, e segno dello zodiaco si trova il Sole, e con quale Stella cammini,
l’indice terzo è della lunazione, che dimostra il giorno della Luna ed il qual grado e segno dello zodiaco.
Due altri indici che sono il capo e la coda del Dragone che dimostrano l’eclissi.”
Francesco Divizioni e il suo quadrante cinquecentesco
 Sulle corone più esterne erano indicate le “case planetarie” con la classica simbologia astrologica che specifica se si tratta di segni fissi, mobili o comuni (FIX, MO, CO), o di segni mascolini o femminei (M o F). Erano pure indicate le caratteristiche del segno in relazione alla teoria aristotelica dei quattro elementi (terra, aria, acqua, fuoco).
Purtroppo l’ingiuria del tempo ben presto scolorì sulla torre il dipinto. Già nel 1623, anno della morte di Francesco Divizioli, si eseguì un primo restauro conservativo, altri ne seguirono.
Un radicale sconvolgimento del quadrante avvenne nel “secolo dei lumi”. L’occasione per il rifacimento generale del quadrante fu offerta ad Amicino Ravizza (1757-1815), insegnante del ginnasio cittadino, costruttore di strumenti scientifici e sopraintendente all’orologio. Convinto assertore del rinnovamento, il Ravizza colse l’ordine dell’Imperial Regio Governo Austriaco che voleva una numerazione per gli orologi pubblici in doppia scala da I a XII, con mezzogiorno e mezzanotte sulla verticale, secondo l’uso d’oltralpe.
In quel rifacimento soppresse gran parte delle indicazioni di carattere astrologico, riducendo così la bellezza, la ricchezza e l’eccezionalità di un quadrante che voleva rendere pubbliche cose che appartenevano soltanto agli uomini dotti. Il moto degli indici è sempre rimasto lo stesso.
Sulle corone più esterne erano indicate le “case planetarie” con la classica simbologia astrologica che specifica se si tratta di segni fissi, mobili o comuni (FIX, MO, CO), o di segni mascolini o femminei (M o F). Erano pure indicate le caratteristiche del segno in relazione alla teoria aristotelica dei quattro elementi (terra, aria, acqua, fuoco).
Purtroppo l’ingiuria del tempo ben presto scolorì sulla torre il dipinto. Già nel 1623, anno della morte di Francesco Divizioli, si eseguì un primo restauro conservativo, altri ne seguirono.
Un radicale sconvolgimento del quadrante avvenne nel “secolo dei lumi”. L’occasione per il rifacimento generale del quadrante fu offerta ad Amicino Ravizza (1757-1815), insegnante del ginnasio cittadino, costruttore di strumenti scientifici e sopraintendente all’orologio. Convinto assertore del rinnovamento, il Ravizza colse l’ordine dell’Imperial Regio Governo Austriaco che voleva una numerazione per gli orologi pubblici in doppia scala da I a XII, con mezzogiorno e mezzanotte sulla verticale, secondo l’uso d’oltralpe.
In quel rifacimento soppresse gran parte delle indicazioni di carattere astrologico, riducendo così la bellezza, la ricchezza e l’eccezionalità di un quadrante che voleva rendere pubbliche cose che appartenevano soltanto agli uomini dotti. Il moto degli indici è sempre rimasto lo stesso.



